|
|
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IL CENTRO CARTAGINESE A CANNE |
la tattica di Annibale a Canne: un approfondimentonicola zotti |
In effetti non si tratta di una frase semplicissima da comprendere. |
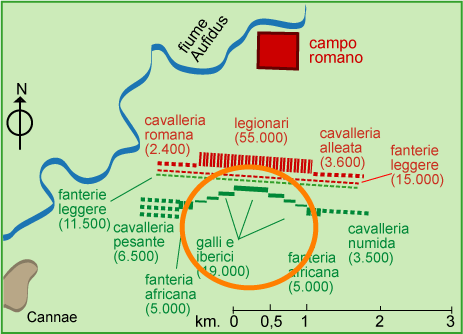 |
Innanzitutto: che cos'è un fianco rifiutato? E' un'ala tenuta distante dal nemico per evitare che entri in contatto con lui e per rendere più problematico un eventuale aggiramento da quella parte. Qui sotto, schematicamente, è illustrata una formazione a scaglioni con il "fianco rifiutato". |
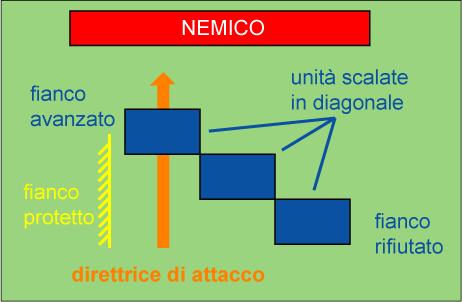 |
L'unità più avanzata è quella che definisce la direttrice d'attacco: in questo caso è rappresentata dal primo rettangolo blu a sinistra. Il fianco rifiutato, in questo caso, è quindi quello destro e le unità risultano scalate in diagonale verso destra: la prima è supportata (sul lato destro) dalla seconda, la seconda dalla terza. Quest'ultima è sufficientemente lontana dal nemico per non essere immediatamente minacciata. Con questo tipo di formazione è evidentemente essenziale che il fianco avanzato (quello "non rifiutato") sia in qualche modo protetto: è infatti particolarmente esposto agli aggiramenti. Deve necessariamente essere appoggiato a "qualcosa" che lo protegga (ad esempio un terreno impassabile), oppure essere condotto ad una tale velocità da moltiplicare il fattore sorpresa e da impedire che il nemico abbia il tempo materiale per approfittare di quella vulnerabilità locale. Nelle fasi conclusive della battaglia di Waterloo, ad esempio, i francesi commisero questo errore per la difettosa comprensione di un ordine. Questa formazione era tipica degil svizzeri di epoca medioevale-rinascimentale, che sul fianco scoperto ponevano un piccolo contingente di truppe scelte e/o di schermagliatori. Annibale, però, a Canne, non si limitò a schierare le sue forze scaglionate: adottò anche il principio dell'economia di forze, come potete vedere dal seguente schema: |
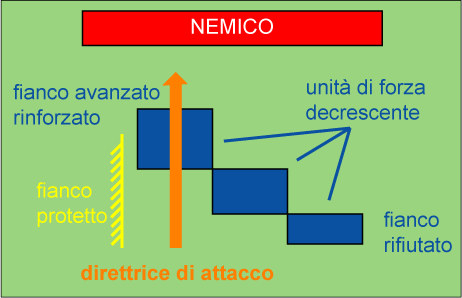 |
Le unità non hanno tutte la stessa "forza": quella principale, la più avanzata, che dovrà sostenere lo sforzo più intenso e prolungato, è maggiore delle successive. Annibale, risparmiando uomini da altre parti, può concentrarli dove gli saranno molto più utili, con lo scopo ultimo di rendere massimo il tempo di resistenza dei galli e degli iberici all'attacco romano. Lo schieramento del centro cartaginese è però un po' diverso da quello che abbiamo visto finora: dobbiamo aggiungere al nostro schema una metà mancante. |
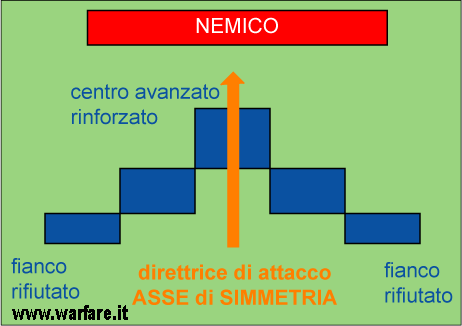 |
Come si può vedere da questo schema, la formazione cartaginese è simmetrica rispetto al suo asse centrale, che è poi la direttrice d'attacco, risolvendo il problema della protezione del fianco "scoperto" o "non rifiutato", che non c'è più. Questo tipo di tattica è stata molto usata perchè permette un graduale impiego delle forze e nello stesso tempo conferisce alla formazione una ragionevole sicurezza per il tempo necessario ad effettuare un attacco. |
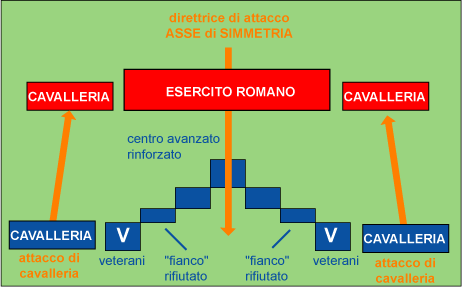 |
|
|
- home - campi di battaglia d'Italia - storie - strategia - tattica - what if? - - colonnina infame - recce - documenti - segnalazioni - vocabolario - link - scrivici - copyright degli autori powered by Angon |

