Annibale
abbandonò l'Italia nell'autunno del 203. Non lo fece
volentieri, ma ormai non aveva più scelta: ridotto
in un angolo del Bruzio, circondato da forze preponderanti
che non era in grado di contrastare, vedeva di giorno in giorno
diminuire i propri alleati e le proprie forze in scaramucce
ed assedi, in una guerra di logoramento nella quale il suo
genio non sarebbe mai potuto brillare. Imbarcò solo
i migliori tra i suoi uomini su quel poco naviglio che riuscì
a reperire probabilmente sacrificando i cavalli e gli animali
da soma.
Finiva così dopo 15 anni la sua permanenza in Italia
e si accingeva, per la prima volta in 36 anni, a rimettere
piede in patria: lui che era stato sul punto di condurre Roma
alla rovina, ora era chiamato a salvare Cartagine dallo stesso
pericolo.
Che cosa rappresentassero per Annibale quella città
e i suoi cittadini, dopo tutto questo tempo passato in altre
terre, nessuno può dirlo. Certo è che i cartaginesi
conoscevano il valore di Annibale ma non lo amavano, si affidavano
a lui, ma lo temevano: davanti al senato romano i messi di
Cartagine che chiedevano la pace giunsero al punto da dichiarare
che la guerra era tutto un equivoco: una questione personale
scatenata da Annibale che aveva disobbedito agli ordini della
città. Qualsiasi sentimento si agitasse nell'animo
di Annibale mentre il suo convoglio attraversava il Mediterraneo,
su una cosa sola non ci potevano essere dubbi: la guerra continuava.
In sé aveva l'energia per riaccenderne il fuoco e per
mare stava viaggiando il combustibile per alimentarlo: i veterani
suoi e di Magone. In Africa, poi, Vermina figlio di Siface
era ansioso di riconquistare il proprio trono.
La speranza dei cartaginesi
Era inevitabile che l'arrivo di rinforzi numerosi ed agguerriti,
e soprattutto quello di un comandate d'eccezione come Annibale,
mutasse l'animo dei cartaginesi, restituendo loro quelle speranze
che solo poche settimane prima avevano perduto.
Le truppe di Magone arrivarono subito dopo quelle di Annibale,
e furono almeno in gran parte avviate là dove quest'ultimo
era sbarcato ponendo la sua base operativa, ad Hadrumentum.
Sotto questa luce i patti stretti con Scipione non apparvero
più né convenienti né tollerabili ad
una gran parte del popolo cartaginese.
Dei mesi trascorsi dall'inizio della tregua, Scipione aveva
approfittato inviando Massinissa a risolvere i suoi problemi
in Numidia, consegnandogli un contingente di fanteria e cavalleria
romana per sostenere con più argomenti le proprie ragioni.
Massinissa, combattendo contro Vermina si era spinto molto
in là, fino ai confini della Mauretania.
Verso la primavera del 202, dunque, le forze di Scipione erano
divise e distanziate da settimane di marce intense ma, nonostante
questo, affrontò la crisi che preludeva alla riapertura
delle ostilità con grande decisione e fermezza.
Un convoglio di 30 da navi guerra e 200 navi onerarie cariche
di rifornimenti per Scipione, fu travolto da una tempesta
e disperso. Le onerarie giunsero con il loro prezioso carico
proprio sotto gli sguardi tanto affamati quanto risentiti
dei cartaginesi e vennero subito poste sotto sequestro. Sarebbe
stato giusto restituirle al legittimo proprietario, anche
perché si trattava di navi sbandate e non di relitti,
e soprattutto sarebbe stato saggio farlo se si intendeva tutelare
la pace: proprio in quelle ore a Scipione erano giunte notizie,
subito comunicate ai cartaginesi, che il senato romano aveva
ratificato gli accordi di pace. Né l'uno né
l'altro motivo sembrarono sufficienti: la guerra riprendeva,
e Scipione non esitò un momento a prenderne atto.
La sua situazione, al momento, non era però delle migliori:
se Massinissa aveva con sé, per ipotesi, 4.000 fanti
e 1.000 cavalieri romani, Scipione non può contare
che su circa 20.000 uomini coi quali deve fronteggiarne almeno
35.000 tra liguri, galli, mauretani, balearici, numidi, italici
di varie etnie, disertori romani, libici e persino cartaginesi.
Senza contare poi 80 elefanti.
Il solo Livio parla anche di 4.000 macedoni, ma è notizia
poco credibile, visto la misera condizione dei macedoni sul
suolo patrio
.
Lo spettro di Fabio Massimo, morto da poco, sembrava prendersi
la sua rivincita e a Roma molti scuotevano la testa: Scipione
stava per affrontare «...non Siface, re di gente barbara
e rozza [...] oppure Asdrubale, comandante noto per le sue
fughe, oppure eserciti raccogliticci adunati in fretta con
una folla mezzo armata di contadini, ma avrebbe dovuto affrontare
Annibale [...] divenuto vecchio in mezzo alle vittorie [...]
ed un esercito mille volte cosparso di sangue romano»
(Livio, XXX 28 3-5).
Il
momento della decisione
Siamo all'inizio della buona stagione del 202.
Scipione abbandonò i Castra Cornelia per penetrare
con decisione verso l'interno, conquistandone le città
e devastando spietatamente i territori: non chiedeva né
accettava rese e i prigionieri venivano posti in schiavitù.
Seguendo la valle del Bagradas proseguì così
per settimane e settimane.
Venne raggiunto dai 600 cavalieri del numida Dakamas, ma Massinissa,
impegnato a fondo dai resti dell'esercito di Siface, ritardava
all'incontro: nonostante il concreto aiuto che gli fornivano
le truppe romane, non riusciva a prevalere su Vermina, che
resisteva strenuamente e cercava con tutte le proprie risorse
di sostenere ancora la causa cartaginese. Altri capi tribali
numidi, come Mazetullo, erano riusciti già a raggiungere
Annibale: in particolare si unì a lui Ticheo, parente
di Siface, con i 2.000 cavalieri più combattivi d'Africa.
Erano così importanti per entrambi questi rinforzi
numidi? La battaglia tra questi due geni dell'arte militare
sarebbe stata decisa da mille cavalieri in più o in
meno? O la manovra di Scipione era più complessa ed
articolata?
Le devastazioni di Scipione provocavano a Cartagine reazioni
violentissime: erano disperse e annientate le ricchezze dei
grandi proprietari terrieri e dei mercanti cartaginesi, che
troppo avevano fino ad allora sofferto per la guerra e non
riuscivano a sopportare questa improvvisa escalation nella
violenza del conflitto, tanto più impressionante in
quanto giunta quando si pensava che qualsiasi limite di orrore
fosse stato già superato.
Cartagine chiedeva dunque ad Annibale di rompere gli indugi
e di passare all'offensiva per fermare questo scempio prima
che non ci fosse più niente da salvare.
Ma Annibale rimaneva sordo a queste richieste, impassibile
nella sua base di Hadrumentum, continuando ad addestrare con
cura le sue milizie, e rispondendo gelidamente che i cartaginesi
lasciassero fosse lui ad occuparsi della gestione delle cose
della guerra.
Annibale valutava la situazione da un punto di vista che ai
suoi concittadini sfuggiva.
La sua immobilità era quella di un animale predatore
che aspettava il momento più opportuno per intervenire.
Non era ignavia: era attesa ansiosa che a ovest si risolvesse
il confronto tra Massinissa e Vermina: la stessa attesa che
viveva Scipione.
Annibale e Scipione sono due velocisti in surplace: che cercano
di sorprendere l'avversario con uno scatto ben piazzato: e
partire con scarso tempismo sarebbe stato fatale.
E Annibale partì all'improvviso verso Scipione, muovendosi
in modo da ridurre la distanza che divideva la sua armata
dall'alleato numida, minacciando nel contempo anche le linee
di comunicazione di Scipione. Giunse così fino a Zama,
a circa 140 chilometri in linea d'aria tanto da Hadrumentum
quanto da Cartagine. La prima preoccupazione di Annibale era
di localizzare il nemico verificando se Massinissa –
del quale non aveva notizie, come non ne aveva di Vermina
– non si fosse già ricongiunto con esso. Diede
incarico a tre esploratori di accertare la situazione: ed
essi ottennero le notizie che il comandante cartaginese cercava,
ma non come si sarebbe aspettato.
Le tre spie, infatti, furono catturate e condotte a Scipione,
ma questi non le passò per le armi, bensì fece
fare loro un giro turistico dell'accampamento e solo quando
questi gli assicurarono di aver tutto ben visto e compreso,
li congedò, fornendo loro anche una scorta affinché
ritornassero senza rischi dal loro comandante.
Allo stesso modo si erano comportati tanti altri generali
dell'antichità: non era un gesto di cortesia, ma un
modo per esercitare una pressione sugli avversari.
Serse, ad esempio, lo aveva fatto per mostrare al nemico tutta
la propria potenza ed intimorirlo: Scipione, probabilmente
per il motivo opposto: voleva far sapere ad Annibale che Massinissa
non c'era ancora. E' un complicato gioco psicologico: perché
Massinissa stava effettivamente per arrivare e Scipione dunque
col suo comportamento dava ad Annibale un'informazione esatta
sì, ma solo ancora per poco tempo.
Dobbiamo credere che Annibale valutò con acutezza il
gesto del romano: non era uomo da lasciarsi incantare, anzi,
forse fu anche irritato da tanta sfrontatezza ed insolenza.
Ma se era un bluff l'unico modo di scoprirlo era andare a
vedere: e questo volle fare, chiedendo un colloquio a Scipione.
Un evento eccezionale, unico nella storia: forse Annibale
sperava di recuperare la pace, ammorbidendo le dure condizioni
dell'accordo appena rotto, forse contava di poter piegare
Scipione, od almeno intimorirlo, con il peso del proprio carisma,
forse era solo curioso di guardarlo negli occhi.
Scipione accettò la proposta di un incontro nel momento
stesso in cui finalmente arrivava Massinissa coi suoi uomini:
ma non era ancora pronto per effettuarlo.
L'iniziativa stava sfuggendogli dalle mani e doveva prima
riprenderla.
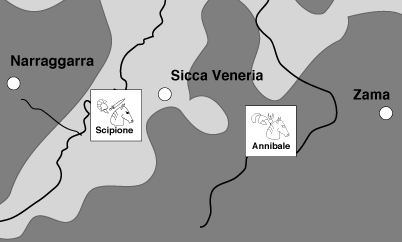
Scipione è comandante di rara raffinatezza strategica:
il suo movimento è quello che si dice "per linee
indirette": ma più indiretto di così, proprio
non si potrebbe. Compì un altro balzo verso l'interno,
fino nei pressi di Narraggarra. E quindi annunciò ad
Annibale che si poteva iniziare a discutere di quale fosse
il luogo migliore per i colloqui.
Immaginiamo la perplessità di Annibale di fronte a
questa inaspettata mossa di Scipione: era evidente che era
stato nuovamente preso d'anticipo e costretto a decidere in
condizioni imposte dall'avversario. Egli sa che Vermina è
lontano, ed è incerto sulla posizione di Massinissa,
non ha più molte possibilità di scelta.
Annibale seguì Scipione verso ovest, spostando il proprio
campo nei pressi di Sicca Veneria: riteneva, infatti, che
se Massinissa aveva raggiunto i romani, il rischio di dare
battaglia non fosse minore di quello di atteggiamenti meno
decisi. Entrambe le armate sono così lontane dalle
loro basi che è come se non ne avessero: ma mentre
per Annibale Cartagine o Hadrumentum erano un perno solido
per la manovra e sarebbero state un rifugio sicuro in caso
di sconfitta, per Scipione i Castra Cornelia rappresentavano
nient'altro che un misero punto di imbarco.
Scipione non solo ha annullato un vantaggio del nemico, risultato
di per se stesso apprezzabile, ma ne ha anche ottenuto uno
di grande portata psicologica e materiale: ha costretto il
nemico a cercare la battaglia ed egli può dunque offrirla
alle condizioni che più riterrà opportune.
L'incontro tra i due ci viene descritto sia da Polibio che
da Livio. E' difficile parlarne senza sentire il rumore della
Storia entrarti nelle orecchie. A poca distanza l'uno dall'alto
ci sono due uomini di eccelsa statura non solo militare ma
umana. Il busto di Scipione ai Musei Capitolini è,
per un felice caso, nella "Sala dei Filosofi" e
lo stesso Annibale avrebbe il diritto di figurarvi, essendo
ben lontano da quel soldato rozzo, avaro e sanguinario che
il risentimento romano cercò di tramandarci.
Il suo discorso è una riflessione solcata da una sottile
disincantata amarezza, che ci consegna un Annibale capace
di guardare a se stesso ed alla propria storia con distacco
per trarne considerazioni valide tanto per Scipione quanto
per noi.
Suggerisce al romano con serena ma severa fermezza di abbandonare
i propositi di guerra, di non tentare la fortuna ancora una
volta, ma di addivenire ad una pace più giusta per
Cartagine, perché "oggi sei tu quello che io fui
a Trasimeno e a Canne" (Livio XXX 30 12).
Annibale ha 45 anni, Scipione 33: la differenza di età
si sente: ma è la diversa condizione strategica a suggerire
la risposta di Scipione: fredda e logica senza margini di
compromesso: era la risposta di chi si sentiva forte e superiore,
era la guerra.
Annibale doveva dunque valutare la sua posizione per la battaglia
che di lì a poco avrebbe deciso le sorti del conflitto.
La sua fanteria era divisa in tre contingenti sostanzialmente
equivalenti di numero. In ordine decrescente di importanza:
12.000 veterani portati con sé dall'Italia, altrettanti
mercenari di Magone, di cui 2000 i frombolieri balearici;
un numero forse lievemente maggiore di reclute cartaginesi.
Per la cavalleria poteva contare innanzitutto sui cavalieri
veterani portati dall'Italia, ai quali aveva trovato delle
monte in Africa, forse mille; su forse altri mille cavalieri
cartaginesi di incerto valore; e sui valenti 2.000 cavalieri
di Ticheo. Infine il suo asso nella manica erano 80 elefanti
africani delle foreste, più piccoli di quelli delle
savane, ma comunque assai pericolosi.
A sud ovest di Sicca Veneria in una vasta pianura dove la
cavalleria ha ampi spazi di manovra, gli eserciti si stavano
schierando.
La battaglia di Zama
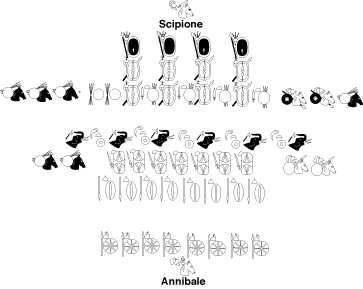
Annibale schierò il suo esercito su tre linee: nella
prima erano i vari nuclei di mercenari, nella seconda, a poca
distanza, le reclute, e infine, ad oltre uno stadio (178 metri)
da questa, la terza ed ultima linea composta dai veterani.
All'ala sinistra presero posto i numidi di Ticheo, alla destra
la cavalleria pesante. Davanti a tutti dispose gli elefanti,
probabilmente insieme ai frombolieri balearici.
Lo schieramento è suggerito ad Annibale dalla qualità
delle sue truppe e, in qualche modo, vincolato ad esse. Ai
mercenari può chiedere un impeto iniziale che si sommi
a quello degli elefanti, ma non resistenza ad oltranza: i
mercenari galli o liguri erano sempre stati travolti dai legionari,
a differenza, ad esempio, dei più ostinati celtiberi.
Dalle reclute non può attendersi molto: possono affrontare
i romani solo dopo che questi siano stati opportunamente ammorbiditi.
Ai veterani, infine, può affidare non solo e non tanto
il colpo decisivo, ma anche qualche tentativo di manovra tattica:
non così complicate come quella di Canne, ma sufficienti
a rispondere alla temuta manovra di aggiramento di Scipione:
che però, probabilmente, Annibale ipotizza essere sul
tipo di quelle spagnole e forse solo teme sia stata resa più
pericolosa dal suo eccezionale avversario.
La profondità dell'esercito cartaginese, dal primo
degli elefanti all'ultimo dei veterani è forse anche
300 metri (500 dai romani), una distanza enorme per l'epoca
e mai raggiunta prima.
Lo schieramento di fanteria è studiato affinché
lo sforzo sia differenziato tra le truppe, e ciò deve
indurci a riflettere su come Annibale intendesse effettuare
il passaggio dello scontro da una linea all'altra. Per certo
non lo sappiamo, perché i resoconti della battaglia
ci aiutano assai poco.
Per esclusione possiamo solo dire che se si considera complicato
da attuare lo scambio tra manipoli di hastati e principes,
che pure erano addestrati lungamente a questo compito, a maggior
ragione questa ipotesi va scartata nel caso dei mercenari
barbari e delle reclute cartaginesi: che tra l'altro non parlavano
nemmeno la stessa lingua. Se, poi, si è disposti a considerare
la difficoltà tecnica e psicologica insita nella manovra
adottata ai Campi Magni dalle legioni, oltre che la sua originalità,
anche in questo caso dobbiamo rigettare l'ipotesi che Annibale
pensasse di far scorrere sui fianchi dei mercenari le sue
reclute, e probabilmente neppure i veterani.
Non rimane dunque che l'ipotesi più semplice e naturale,
la stessa che viene considerata abituale per l'intervento
dei principes: l'opposizione dei ranghi, ovvero non un subentro
di linee, ma un semplice sostegno reciproco o al massimo una
giustapposizione.
Questa ipotesi, però, non coinvolge i veterani, che
sono troppo distanziati dalle altre linee per poterle soccorrere:
la spiegazione l'avremo nel corso della battaglia.
Elefanti e mercenari costituiranno due onde d'urto successive,
le reclute cartaginesi forniranno un sostegno e un rincalzo,
in riserva i veterani inizieranno una battaglia nuova, scontrandosi
contro forze romane logorate.
Sulla propria cavalleria Annibale non ripone molte speranze
perché ne conosce l'inferiorità numerica: se
l'apporto degli elefanti sarà quello che auspica, però,
almeno sarà sufficiente a neutralizzare quella romana
e a ridurre la battaglia ad uno scontro tra fanterie, nel
quale prevarranno quelle più fresche.
Scipione schierò i suoi uomini sulle consuete tre linee,
ma anziché alternare i manipoli nell'usuale formazione
a scacchiera, diede disposizioni affinché i manipoli
di principes prendessero posto alle spalle degli hastati:
con questo stratagemma Scipione intendeva creare dei canali
di scorrimento per gli elefanti, che lo preoccupavano non
poco, perché nessuno tra i suoi uomini, per quanto
veterano, poteva essere abituato alla carica di 80 pachidermi.
E per essere sicuro di indirizzare gli animali in quei corridoi,
utilizzò i velites come esca: sarebbero stati loro
ad assorbire il primo impatto con gli elefanti.
All'ala destra, dispose Massinissa con i suoi 3000 numidi,
alla sinistra Lelio con la cavalleria romana ed italica (in
tutto non più di 2.000), e forse un po' di altri numidi.
Dopo qualche schermaglia tra numidi, Annibale aprì
le ostilità ordinando agli elefanti di caricare: confidava
che gli animali sarebbero riusciti a provocare nella prima
linea romana uno scompiglio sufficiente ad avvantaggiare l'attacco,
subito successivo, che doveva essere portato in successione
dalle altre due linee.
Le cose, però, non andarono esattamente così:
una parte degli animali, spaventati dai suoni dei corni provenienti
dalle fila romane, si rivoltò contro le linee cartaginesi
travolgendo la cavalleria di Ticheo. Massinissa ne approfittò
con grande tempismo, caricando e ponendo in fuga il nemico
disordinato. In condizioni simili, dall'altro capo del campo
di battaglia, Lelio mandava in rotta la cavalleria pesante
avversaria e così, già nella prima fase della
battaglia, la linea cartaginese non aveva più protezione
sui fianchi
I fuggiaschi sfilarono lungo tutta la profondità della
formazione cartaginese e scomparvero inseguiti dalla cavalleria
romana fuori dal campo di battaglia. Se già non se
ne era accorto, Scipione ora è stato informato dai
suoi luogotenenti sullo schieramento distanziato dei veterani.
Non è una buona notizia, perché gli impediva
la famosa manovra di aggiramento, almeno fino a quando non
fossero state sconfitte le altre due linee di fanteria.
Gli elefanti ebbero più successo al centro, ma non
poi tanto, che fu la parte spendibile dell'esercito romano,
i velites, a pagare il prezzo più pesante, mentre hastati
e principes uscirono indenni o quasi dagli effetti devastanti
della carica.
Scipione ha ottenuto un primo risultato: la sua linea è
rimasta ordinata, gli hastati sono integri e i principes non
sono stati coinvolti.
I due schieramenti ora avanzarono l'uno verso l'altro, ad
eccezione dei veterani cartaginesi che tennero la posizione:
quindi la loro distanza dalla linea di combattimento aumenta
a circa 400 metri.
Sulle prime i mercenari riportarono qualche successo, ma era
un successo fragile. La loro linea, infatti, non aveva tutta
la medesima consistenza: resisteva e combatteva a seconda
della nazionalità e delle caratteristiche di ciascuno:
i galli essendo diversi dai liguri ed entrambi diversi dai
mauretani e dai balearici.
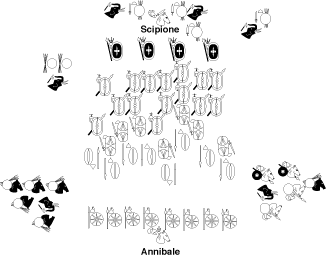
Ne nacque così una mischia assai confusa, con grandi
varchi che si aprivano nella formazione di mercenari che permettevano
agli hastati (o forse agli stessi principi) di attaccare ai
fianchi i nemici più caparbi. La formazione delle reclute
non intervenne subito a sostenere queste unità mercenarie
minacciate da più lati, perché il fronte era
ingombro di fuggitivi, e non concesse a questi ultimi di attraversarla
per porsi in salvo, in modo da non far disordinare i propri
ranghi: si originò qualche scaramuccia tra mercenari
e reclute, che deve aver suggestionato ben oltre la sua reale
importanza i testimoni della battaglia tanto da venire enfatizzata
da Polibio.
Comunque, appena ebbero il fronte sufficientemente libero,
alcuni reparti di reclute si unirono alla mischia chiudendo
il contatto con gli hastati, proprio laddove questi erano
più disordinati per aver cercato di avvantaggiarsi
della fuga dei mercenari: qua e là, dunque, qualche
manipolo di hastati non doveva aver ancora recuperato la posizione
e la saldezza e dovette chiedere il supporto dei principes
per reggere all'impeto, non certo altrimenti insostenibile
delle reclute.
Questa fase della battaglia deve essere durata pochi minuti:
dobbiamo tentare di figurarci il caos nelle due linee cartaginesi
ora mischiate, il disordine e la concitazione degli hastati,
la tensione dei principes.
Pochi minuti ma terribili, perché la lotta era spietata
e si svolgeva in spazi ristretti. Sono momenti drammatici,
ma ancora una volta i romani riescono a prevalere in virtù
del loro migliore addestramento individuale e del loro armamento.
I mercenari, duramente provati, finalmente fuggirono e le
reclute con loro. Di queste ultime, però non tutti
sono stati impegnati e il loro ripiegamento soprattutto se
iniziato con un certo anticipo deve essersi svolto in modo
sufficientemente ordinato e composto da non trasformarsi in
rotta: tale inevitabilmente sarebbe stata se il collasso fosse
stato improvviso.
Così i soldati delle due prime linee cartaginesi, chi
fuggendo chi indietreggiando, abbandonano la linea di combattimento.
Gli hastati, i più coinvolti psicologicamente e fisicamente
nella lotta, esultano e si danno all'inseguimento: è
un errore e se l'esperienza precedente non li ha istruiti,
ha messo, però, sul chi vive Scipione che è
pronto a spendere ogni energia sua e del suo apparato di comando
per richiamarli e trattenerli, impedendogli di sfiancarsi
correndo per i 400 metri che li separano dai veterani cartaginesi.
Questi a loro
volta, però, non possono approfittare dello sbandamento
romano: sono lontani e bloccati dalle unità amiche
in fuga.
Il combattimento qui ha una pausa, durante la quale le formazioni
contrapposte affrontano una riorganizzazione: Annibale riesce
a riprendere sotto il suo controllo alcune delle unità
di reclute e di mercenari, anche in virtù della distanza
che ha lasciato tra la prima e l’ultima linea. Una distanza
sufficiente non solo a compiere qualche manovra, ma anche
a permettere che i fuggitivi fossero riorganizzati e convinti
a tornare al combattimento.
Con queste unità estende il proprio fronte, allineandole
ai fianchi dei veterani.
Scipione, invece, una volta riorganizzati gli hastati può
finalmente far compiere ai suoi legionari la tanto celebrata
manovra di movimento sui fianchi: non per aggirare il nemico,
ma solo per estendere da un lato e dall'altro il fronte degli
hastati. In linea teorica, data una distanza percorsa di 750
metri, sono sufficienti circa 8-10' per eseguirla.
Il combattimento, quindi, sta per conoscere un'ultima decisiva
fase: i veterani ancora freschi se la vedranno con gli hastati,
che freschi non sono, e con principes e triares, che invece
hanno molte energie da spendere.
La fronte romana è probabilmente di ugale entità
rispetto a quella cartaginese, o forse lievemente superiore:
in entrambi i casi triari e principes si trovano a combattere
sulle ali contro forze più provate e quindi sono in
condizioni di grande vantaggio.
Il combattimento si riaccende tempestosamente e le sue sorti
rimangono sospese.
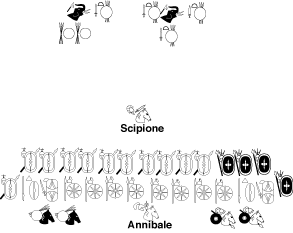
Non per molto, però, perché Lelio e Massinissa,
forse da tempo ai margini del campo di battaglia ad aspettare
proprio questo momento, tornano dall'inseguimento e piombano
alle spalle dei cartaginesi decretandone la fine.
Si conclude così la battaglia, seppellendo le speranze
di Cartagine ed elevando Roma ad incontrastata dominatrice
del Mediterraneo. Da quel giorno in poi Publio Cornelio Scipione
sarebbe stato conosciuto con l'appellativo di Africano: e
con quel nome lo ricordiamo noi oggi.
<
4) Il preludio della fine
|